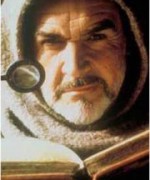Il sorriso: storia, cultura e odontoiatria
21.10.2012
“ Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno.”
F. Schiller
Questa felice espressione del poeta e filosofo tedesco
Friedrich Schiller esprime in forma suggestiva, tutto il fascino ed il mistero di un’espressione mimica, il sorriso, che è sempre stata oggetto di studio e discussione, talora con implicazioni sociali e culturali di grande rilevanza.Può essere interessante proporre una breve storia di quanto è stato detto e scritto sul sorriso, dalle origini della nostra civiltà sino alle interpretazioni attuali, anche secondo una lettura più scientifica e psicologica.Il termine “sorriso” deriva dal latino “sub-ridere” e indica un gesto attenuato rispetto al riso vero e proprio. Per intenderci se il riso viene comunemente accostato alla comicità, il sorriso è proprio dell’umorismo. Nel nostro immaginario il sorriso è più moderato, discreto, persino meno licenzioso della risata, termine che può essere accompagnato da aggettivi quali “sonora”, “sguaiata”, “cristallina” e via dicendo.
Il sorridere, per sua natura discreto, talora ambiguo, non si presta ad interpretazioni unilaterali: ha significati più misteriosi e intriganti. In questo senso l’esempio forse più noto è l’enigmatico sorriso di Madonna Annalisa Gherardini, ai più nota come Monna Lisa. Per inciso, una nostra valente collaboratrice è la Dr.ssa Annalisa Gherardini…Se al tempo dei miti greci il riso degli Dei era considerato energia che permeava il cosmo e creatrice di tutte le cose mondane, i filosofi greci cominciarono a gettare qualche dubbio in merito.
Aristotele, per chiudere ogni questione in merito, definì il riso “brutto e deforme.“Come al solito il Filosofo per eccellenza non lasciava molto spazio al dibattito… Tuttavia considerava il sorriso “pacato ed educato che non offende ma si avvale del tatto proprio degli uomini virtuosi.” Bontà sua…Nonostante nella
Bibbia si ritrovino parole di sostegno al riso ed al sorriso (nel libro dei Proverbi si legge che “un cuore gioioso distende la faccia, nella tristezza del cuore si deprime lo spirito”), le certezze espresse dal filosofo greco, trovarono puntuale applicazione nella cultura dominante medioevale. Doveroso, a questo punto, ricordare il capolavoro di Umberto Eco “Il nome della rosa”, così come la bella rivisitazione cinematografica con Sean Connery calato nel personaggio del dotto e sorridente Guglielmo da Baskerville.
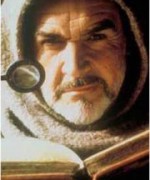
E tuttavia se il riso è considerato volgare se non demoniaco, il sorriso rimane accettabile per quei tempi e talora anche desiderabile. Scrive infatti
Clemente Alessandrino (145-212 d.c.): ”Lo spianare urbanamente il volto, di modo che le sue linee diventino armoniche, come le corde di uno strumento, si dice sorriso, è questa un’espressione dolce che risplende nel volto, e questo è il riso dei saggi.”Con l’Umanesimo ed il Rinascimento, la mortificazione del corpo e dello spirito lasciano il posto ad un pensiero assai più propenso ad accettare l’uomo e le sue emozioni, addirittura come espressioni del divino. In altri termini la rivalutazione dello spirito dei classici e le nuove idee consegnano al sorriso ed al riso la dignità perduta.
Bacone, Cartesio, Kant, Leibniz, Spinosa dissertano sul sorriso riconoscendone l’elevata valenza spirituale.Soltanto nel XX secolo il sorriso diventa oggetto di argomentazioni scientifiche e, dunque, sociologiche, psicologiche e mediche.Christian de Bartillat ci ricorda che il sorriso vero è inscindibile dalla tenerezza e dalla bellezza e può nascere solo nell’animo di chi ha riscoperto in sé lo stupore del bambino. Nella società moderna della comunicazione il sorriso è più spesso veicolo di messaggi di benessere economico. La pubblicità ne fa un uso smodato quanto stereotipato.

In realtà il sorriso è un atto innato ed automatico nel neonato, che compare anche nel sonno nelle prime due settimane di vita. Soltanto a partire dalla quarta settimana esso acquisisce una valenza “sociale” per cui è legato al riconoscimento di volti o cose familiari. Ancor più in là il bambino impara che il sorriso è un potente mezzo a propria disposizione per ottenere soddisfazione a bisogni e desideri.A livello fisiologico sicuramente il sorriso favorisce la capacità respiratoria, la circolazione sanguigna e varie altre funzioni, tra cui la capacità di “guarire”. In ogni caso molto resta da scoprire (verrebbe a dire: per fortuna…).La fisiognomica è una scienza, per alcuni una pseudoscienza, che studia le espressioni, la mimica dei volti in chiave psicologica, talora etica (vd. i celebri studi di Lombroso). Il sorriso è ovviamente un importante fonte di studio.

In questo senso il sorriso, come espressione non verbale, può esprimere una gamma vastissima di significati: da semplice espressione di calore, disponibilità a rituale convenzione sociale, espressione addirittura di distacco e di mantenimento delle distanze.Solitamente un bel sorriso si identifica in un sorriso perfetto anche da un punto di vista odontoiatrico ed ortodontico, possibilmente molto bianco, spesso troppo bianco. In realtà colore e forma dei denti sono in stretto rapporto con vari tratti della conformazione del viso: le ali del naso, gli zigomi, le arcate sopracigliari ed altri elementi. Quando ci troviamo di fronte a riabilitazioni odontoiatriche complesse dobbiamo assolutamente tenere in conto l’insieme di questi fattori. Occorre dialogare con il Paziente, cercare di comprendere cosa egli si aspetta dai propri denti e dal proprio sorriso. Come direbbe Benedetto Croce “la forma che diventa sostanza”.
Dunque progettare un sorriso è un po’ come progettare la casa dell’anima, una casa accogliente, funzionale, costruita su solidi principi scientifici ma anche e necessariamente, a misura dell’anima medesima.La domanda è: cosa c'entra tutto questo con le attività cliniche che si svolgono nel mio Studio? Poco, forse nulla o, almeno nelle mie intenzioni, moltissimo. Perché un atto medico è nella sua essenza un fatto intellettuale e culturale. Se manca quest'ispirazione qualsiasi professione diventa un mero tecnicismo, più o meno rilevante ma comunque tale. La conoscenza può dunque limitarsi alla tecnica? La mia risposta è NO, quest'articolo è un semplice NO
Anglesio Farina Giovanni